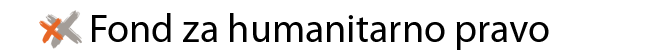Nataša Kandić: ora sono un’altra persona, a me più cara
![]() Dallo scorso dicembre Nataša Kandić ha passato il testimone, non è più direttrice del Centro per il diritto umanitario (FHP). Il bilancio e alcune memorie della sua lunga esperienza di attivista per i diritti umani
Dallo scorso dicembre Nataša Kandić ha passato il testimone, non è più direttrice del Centro per il diritto umanitario (FHP). Il bilancio e alcune memorie della sua lunga esperienza di attivista per i diritti umani
(Pubblicato originariamente sul quotidiano belgradese Danas il 9 febbraio 2013)
Da quando dal dicembre dell’anno scorso non sono più direttrice del Centro per il diritto umanitario (FHP), è come se fossi un’altra persona, a me più cara. Mi sento più libera, più mia. Vivo in pace con quello che faccio.
Sono la presidentessa del Consiglio di amministrazione del Centro per il diritto umanitario del Kosovo (FHP Kosovo), fondatrice dell’FHP di Belgrado e membro del Consiglio di amministrazione del Fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. Inoltre, coordino il team congiunto dei ricercatori di FHP e FHP Kosovo che lavorano sulla documentazione in merito alle vittime di guerra in Kosovo. Così come del team di FHP che registra le vittime tra soldati, poliziotti e volontari della Serbia e Montenegro nelle guerre in Croazia e in Bosnia Erzegovina e del gruppo di persone che registra le vittime serbe civili e militari tra i cittadini della Croazia.
Oggi esistono due Centri per il diritto umanitario. FHP Kosovo che ha vita indipendente dopo che dal 1995 al 2010 operava come ufficio dell’FHP in Kosovo. Il suo direttore adesso è Bekim Blakaj, che ha lavorato per sette anni come ricercatore sui crimini di guerra in Kosovo. A vent’anni dalla sua fondazione anche l’FHP ha una nuova direttrice: Sandra Orlović, che per cinque anni è stata la mia vice e la coordinatrice del progetto: “Libro dei ricordi del Kosovo”. Il nuovo management, di entrambi i Centri, condivide lo stesso database che abbiamo creato insieme. Questo database, oltre al voluminoso materiale sui crimini di guerra in Kosovo, contiene anche una rilevante documentazione sui crimini di guerra in Croazia e Bosnia Erzegovina. Nella stesura del nuovo programma entrambe le organizzazioni godono di un forte sostegno anche grazie alla raccolta di questi materiali nell’archivio pubblico del Tribunale dell’Aja, cosa che mi convince ulteriormente che avranno un futuro e che “sopravvivranno” al loro autore.
A me ora resta dedicarmi ai lavori incompiuti del passato. Uno di questi importanti lavori l’ho iniziato nel lontano ottobre 1991, quando i media governativi in Serbia e in Croazia, nei loro resoconti sulle persone uccise o perite, cessarono di dire i nomi delle vittime ma iniziarono a gareggiare sulla pubblicazione dei numeri di morti “ustaša”, “četnici” e della “jugovojska”. Dal 1991 sino all’8 febbraio 1992, nel Parco dei pionieri, accanto al palazzo della Presidenza della Serbia, ogni sera, dalle 8,30 alle 9,00, in una trentina di persone esprimevamo il sostegno ai disertori della guerra “accendendo delle candele”. Ogni due-tre sere leggevo i nomi delle persone uccise o morte in quel periodo in Croazia, prescindendo dalla loro appartenenza etnico-nazionale.
Nel novembre 1991 seppi del suicidio di Miroslav Milenković, riservista di Gornji Milanovac. Per la prima volta, dopo aver pronunciato il nome, mi fermai per poi proseguire con la sua storia personale: “Nato nel 1951, operaio edile, padre di due bambini, chiamato alle armi il 19 settembre 1991, si è suicidato il 20 settembre 1991 al mercato del bestiame a Šid fra due gruppi di riservisti. In mezzo, tra quelli che avevano abbandonato i fucili e gli altri che li hanno imbracciati per andare verso Tovarnik, al fronte”.
Ho avuto bisogno di molto tempo per capire che i nomi sono la chiave per affrontare il passato, la costruzione della solidarietà e una nuova cultura dei ricordi. Da questa consapevolezza sono partiti svariati anni di ricerca di FHP e FHP Kosovo, a raccogliere le dichiarazioni dei membri delle famiglie e dei testimoni, le fotografie, i rapporti, la documentazione del tribunale e altre fonti che contengono i dati sulle persone che hanno perso la vita in Kosovo tra l’1 gennaio 1998 fino alla fine del dicembre 2000.
Le famiglie delle vittime, sia in Kosovo che in Serbia, hanno accolto il “Libro kosovaro dei ricordi” come una storia di vita attendibile delle 2.050 persone che hanno perso la vita nel 1998. È il riconoscimento più grande che io ed entrambi i Centri abbiamo mai ricevuto. Per la fiducia datami ho l’obbligo morale e professionale di portare a termine questo lavoro. L’obiettivo è di verificare, con la squadra dei ricercatori in Kosovo e in Serbia, il materiale raccolto e di finire di redigere il testo sulle 11.881 vittime della guerra in Kosovo.
Poi c’è anche l’elenco dei 1.678 cittadini di Serbia e Montenegro che hanno perso la vita nella guerra in Croazia e Bosnia Erzegovina. E soprattutto c’è la documentazione in merito alle vittime di guerra in Croazia, raccolta in collaborazione con il centro Documenta di Zagabria.
Censendo i civili e i soldati che hanno perso la vita nelle guerre degli anni novanta, REKOM [un’iniziativa regionale volta ad accertare i fatti avvenuti durante i dieci anni di guerre in ex Jugoslavia, ndt] sta diventando una realtà sempre più concreta che si oppone alle statistiche fabbricate, all’ingrandire, al minimizzare, al negare e manipolare i dati sulle vittime: dare sostegno a questa rete è il mio secondo compito, inseparabile dal primo. La nomina di rappresentanti personali del presidente di Croazia, Montenegro e Macedonia presso il Gruppo regionale di esperti di REKOM sono quelle buone decisioni politiche che mi aspetto compiano anche il presidente della Serbia e della Slovenia, la presidentessa del Kosovo e la presidenza della Bosnia Erzegovina. Soltanto loro possono garantire che dietro a REKOM e alle vittime vi siano gli Stati.
Tutt’oggi mi turba il rapporto che i serbi hanno verso i musulmani che ai tempi della dissoluzione della Jugoslavia lavoravano nelle imprese edili a Belgrado. Ho dovuto supplicare più volte l’amministrazione della polizia di frontiera della Serbia e l’Ufficio della Republika Srpska di permettere a queste persone di visitare le loro famiglie a Janja [nella municipalità di Bijelijna, Republika Srpska, ndt] e di poter poi tornare a Belgrado dove lavoravano. In frontiera venivano insultati, chiamati turchi, balije, erano costretti a stare per ore in un angolo dei container o al freddo, spaventati dai nomi di Arkan e Šešelj. Tutto faceva parte del consueto repertorio della polizia verso i musulmani che più tardi i “patrioti” replicheranno nei confronti degli albanesi. La base di partenza comune di tale atteggiamento era che i musulmani e gli albanesi avessero meno valore dei serbi.
Quando iniziarono i bombardamenti della NATO tutti apparimmo sotto la vera luce. Per i primi due-tre giorni la gente aveva paura del buio per le strade, e quando il governo riaccese la luce – ma non in Kosovo – molti osservavano gli aerei dai bar. Il Kosovo era lontano. A nessuno importava che l’esercito e la polizia della Serbia stavano cacciando gli albanesi dai villaggi e dalle città, che uccidevano i civili, che bruciavano loro le case e rubavano le loro proprietà. Tutti gli albanesi venivano trattati come terroristi. Sia i neonati che gli anziani.
Il 27 marzo 1999 andai in Kosovo per vedere cosa stava accadendo agli albanesi che lavoravano nell’ufficio del nostro Centro. Ebbi la fortuna di trovare per strada un tassista che accettò di portarmi fino a Priština. Arrivai e vidi colonne di gente cacciata fuori dalle proprie case che andavano verso la stazione ferroviaria. Dopo due giorni, con tre collaboratori albanesi del posto, tornammo verso Belgrado. Ai punti di controllo celavo la mia paura per rincuorarli. A Gnjilane ci fermarono ad un posto di blocco militare. Ci obbligarono tutti a scendere dalla macchina e a consegnare i documenti. Un giovane soldato con incredulità guardava i nomi sulle carte d’identità. L’ufficiale che aveva preso i documenti stupito ci chiese chi eravamo e dove stavamo andando. Alla mia spiegazione che eravamo un’organizzazione umanitaria e che era giunto il momento in cui dovevamo aiutarci a vicenda, iniziò a girare su se stesso… In modo frettoloso poi ci restituì tutti i documenti, pronunciando soltanto due parole: “Buon viaggio!”. Fino a Belgrado continuammo a voltarci indietro per vedere se qualcuno ci stesse seguendo.
A Belgrado gli intellettuali firmarono una lettera di protesta indirizzata alla comunità internazionale chiedendo la fine dei bombardamenti sulla Serbia e Montenegro. Quella lettera, la cui autrice era Sonja Liht, all’epoca presidentessa della Fondazione di Soros in Serbia, non la firmammo Filip David, Ivan Čolović ed io. Ritenevamo che avrebbe dovuto essere Milošević il suo vero destinatario.
Durante i bombardamenti della NATO tutta la Serbia si era stretta attorno a Milošević contro l’America, la NATO e l’Europa. E i servizi segreti si occupavano del ricercatore dello Human Rights Watch – uno studente tedesco che avevano picchiato sulla frontiera con la Croazia – di giornalisti australiani sospettati di spionaggio e del centro FHP. Al personale che presenziava gli uffici di Belgrado avevano detto di non dire nulla delle visite che facevano nei locali della nostra organizzazione.
La pubblicazione dell’accusa del Tribunale dell’Aja contro Slobodan Milošević, il 22 maggio 1999, fece arrabbiare i generali dell’esercito, della polizia e dei servizi segreti. Dopo la proclamazione della “vittoria” [della NATO, ndt] quando alcuni media come il quotidiano Danas iniziarono a scrivere dei crimini commessi in Kosovo, nel mirino finirono tutti quelli che i servizi di sicurezza sospettavano avrebbero detto qualcosa in merito.
Ma a differenza della paura provata negli anni ottanta, durante i bombardamenti della NATO non temevo i servizi segreti. Quella vecchia fredda paura la sento sempre quando mi viene in mente l’arresto di Danilo Udovički nel 1972, l’intrusione notturna di almeno 20 poliziotti nella casa dove abitavamo insieme. Oppure l’arresto di Lazar Stojanović, nel 1984, quando mi portarono via Storia critica dell’opinione pubblica di Jürgen Habermas, in quanto libro dal contenuto nemico. Con questa esperienza alle spalle, l’incontro con i servizi di sicurezza durante i bombardamenti della NATO era qualcosa di completamente diverso.
Accadde il 22 maggio 1999, il giorno della pubblicazione dell’accusa contro Slobodan Milošević. Da Priština in auto andavo verso Prizren. Mi portava un amico della mia collaboratrice, serbo, un pilota d’aereo che preoccupato per la guerra era appena rientrato da qualche paese lontano. Il fatto che non fossimo passati attraverso Brezovica, che era sotto il controllo delle forze VJ/MUP [esercito e polizia serbi, ndt], ma eravamo sulla strada per Dulja, per la polizia del checkpoint fu la prova che non eravamo “dalla parte giusta”. Seguì la perquisizione dell’automobile, la confisca di “materiale nemico” e la consegna agli uomini dei Servizi di sicurezza statali, ben nascosti in una casa privata di Uroševac.
L’interrogatorio durò ore. Il povero pilota fu minacciato di morte, allo stesso modo fu per “chiunque conoscesse l’inglese”. Di me si “occuparono” in due. Uno era il buono e l’altro urlava, si metteva sopra la mia testa, minacciava di accusarmi di spionaggio, che mi avrebbero ucciso per poi dire che mi aveva rapita l’UCK… Ad un tratto, tutto d’un fiato iniziai ad elencare tutti i crimini e i furti che conoscevo. “Avete ucciso Fehmi Agani”, dissi, “avete ucciso Bajram Kelmendi e i suoi figli, avete ucciso contadini, donne e bambini”… ad alta voce elencavo tutto, decisa a non fermarmi, a costo che mi sparassero. Il membro dei servizi che prima mi urlava ora se ne stava zitto e mi pareva si fosse rimpicciolito. Poi al “capo “ squillò il telefono. Si alzò e con voce impersonale mi disse che a Belgrado avevano deciso di lasciarmi andare. Nel settembre 1999 durante una visita ai prigionieri serbi nel carcere di Priština, Aleksandar Mladenović, nato a Uroševac, mi rivelò che tutti in città sapevano che i Servizi di sicurezza mi avevano interrogata per “spionaggio”.
Il Tribunale dell’Aja ci ha tolto la possibilità di dimenticare il passato. L’eredità del Tribunale dell’Aja è più grande e più significativa di tutti gli errori e le sentenze provvisorie, prive di una spiegazione giuridica. Il tribunale ogni giorno ci rivela i volti dei criminali di guerra che i tribunali locali nascondono. Alle generazioni future lascia le sentenze e i fatti sui misfatti. Non è riuscito a ottenere o a costringere gli stati della regione a processare i rispettivi generali. E anche quando ciò accade, la pena simbolica è accompagnata dalle proteste e dall’esaltazione degli “eroi”. I più numerosi sono i processi ai diretti esecutori che ormai non nascondono più che gli era stato permesso di uccidere i civili dell’altra parte. In questo senso, l’eredità del Tribunale completa il quadro su cos’è accaduto, come e perché.
Il processo ai membri degli Scorpioni, l’Unità dei Servizi di sicurezza serbi, per aver ucciso sei musulmani di Srebrenica arrestati nel luglio 1995, non è andato dal punto di vista processuale diversamente dagli altri processi presso il Tribunale per i crimini di guerra in Serbia. Alla fine, il tribunale li ha dichiarati un gruppo di criminali e per le vittime ha stabilito che non vi sarebbero prove che si tratti di musulmani di Srebrenica. La vergogna e l’imbarazzo per questa sentenza sono stati attenuati solo dalla pubblica reazione dei cittadini della Serbia che per la prima volta si sono messi dalla parte delle vittime.
In questo senso è stato decisivo il video sull’esecuzione dei prigionieri di Srebrenica. La gente ha visto i visi delle persone, giovani ragazzi che in silenzio aspettavano la loro pallottola, e il volto di quelli che sparavano ancora dopo la ventesima pallottola. Nessuno ha sputato sul membro degli Scorpioni che per giorni, nel luglio 2002, nascondendosi in casa mia mi raccontava della sua esperienza di guerra e di come gli Scorpioni avessero preso parte al massacro dei musulmani di Srebrenica. Questo testimone, così come il membro degli Scorpioni che mi ha consegnato il video, vivono lontano dalla Serbia, sotto una nuova identità. Non certo per paura della gente normale ma per la possibile vendetta dei membri degli allora Servizi di sicurezza serbi.
Ho ricevuto tanti riconoscimenti, soprattutto internazionali. A New York è appena uscito il libro “Giustizia nel mondo”, dedicato alle cento persone che hanno contribuito alla giustizia sul pianeta. Fra i nomi di Desmond Tutu, Louise Arbour, Richard Goldstone … c’è anche il mio. Sono felice anche del premio del comune Lovas, in Croazia, ricevuto anche dal giudice Olivera Anđelković che a Belgrado ha processato e sentenziato per i crimini compiuti in questo villaggio. È la prima volta che un giudice della Serbia riceve un premio croato. Per ben due volte il Time mi ha nominata eroe d’Europa. E ancora oggi per questo mi sento un po’ in imbarazzo. Non ho mai pensato di essere un eroe.